|
Le
basi della forza
di
Gian Nicola Bisciotti
Un’analisi
delle reali necessità del calciatore
e una strategia articolata in più
tappe per ottenere i migliori risultati
in allenamento senza correre rischi inutili.
L’aumento
delle capacità di forza è
legato a fattori di tipo strutturale e nervoso,
oltre che a parametri direttamente connessi
con le proprietà elastiche del complesso
muscolo tendineo. Per comprendere meglio
le basi neurofisiologiche su cui si fonda
l’incremento delle capacità
di forza del muscolo
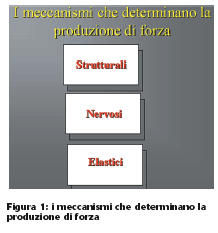
scheletrico, prenderemo ora brevemente in
esame i tre fattori sopra indicati (figura
1), considerando anche il loro diverso
"peso" nell’ambito della
metodologia dell’allenamento rivolta
all’incremento della forza.
I fattori
strutturali
Possono essere suddivisi in tre categorie
principali, la prima comprende quelli legati
all’ipertrofia muscolare, la seconda
quelli connessi alla tipologia delle fibre,mentre
la terza riguarda i parametri correlatialla
struttura sarcomerale del muscolo.
Il fattore
ipertrofico
L’ipertrofia
muscolare, è dovuta a numerosecause
e le principali sono:
l’aumento
del diametro delle miofibrille;
l’aumento del numero delle miofibrille
all’interno del muscolo; l’aumento
di tessuto connettivo;
l’aumento
della vascolarizzazione.
Il
possibile aumento del numero dellefibre
è determinato dal meccanismo conosciutocon
il nome d’iperplasia. L’iperplasia,anche
se accertata sull’animale, èancora
motivo di discussione e di parericontrastanti
per ciò che riguarda l’uomo.La
sezione traversa del muscolo scheletrico(Cross
Sectional Area, CSA) è direttamentecorrelata
alla forza estrinsecabileda quest’ultimo.
In altre parole, piùGian Nicola Bisciottile
basidellafforzagrande è il volume
del muscolo, maggioresarà la forza
che quest’ultimo puòprodurre.
Questo concetto è facilmentecomprensibile
grazie a un esempio poco"fisiologico".
Se noi prendiamo un vecchioestensore a molle,
riusciremmo facilmentea estenderlo se lo
utilizziamocon una sola molla, ma se cominciamoad
aggiungerne, il compito sarà semprepiù
difficoltoso. L’estensore, infatti,
conl’aggiunta di una molla dopo l’altra,
opporràsempre maggior resistenza,
ossia,"umanizzando il concetto",
diverrà semprepiù forte.
Nel muscolo scheletrico avviene più
omeno la stessa cosa: l’aumento in
volume(ipertrofia) — o come alcuni
autorisostengono anche nel numero (iperplasia)dei
suoi elementi (le fibre) — che siverifica
in parallelo, proprio come nelcaso dell’estensore,
permetterà un aumentodella produzione
di forza da partedel muscolo stesso. Quest’importantecorrelazione
che si riscontra tra il volumedel muscolo
e le sue capacità contrattili,si
verifica però sino a un certo limited’ipertrofia.
Oltre, infatti, il volume muscolarepuò
continuare ad aumentare, male capacità
di forza cresceranno in modomeno evidente.
Questo fenomeno è palesenel caso
dei culturisti, che sono appuntogli "specialisti"
dell’ipertrofia,atleti senza dubbio
forti ma comunquemeno di altri, come ad
esempio i sollevatori di peso, che possiedono
delle masse muscolari meno ipertrofiche.Quest’appiattimento
della curva che descrivela relazione tra
volume muscolaree forza, è dovuto
principalmente al fattoche, oltre un certo
limite di volume muscolare,i muscoli pennati
e bipennati(nei quali le fibre s’inseriscono
obliquamenterispetto all’asse centrale
come lepiume sull’ala di un uccello,
da qui illoro nome) subiscono un forte cambiamentodell’angolo
di pennazione, che divienesempre più
sfavorevole, limitandole possibilità
di espressione di forza daparte del muscolo
(figura 2).
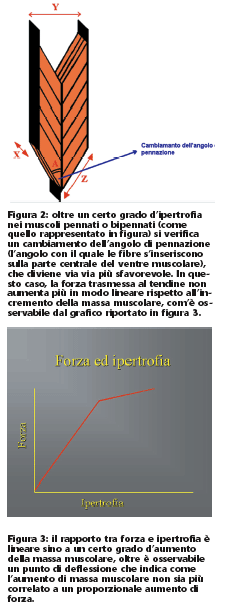
Il fenomeno ipertrofico (figura 3)
è legatoa una forte deplezione delle
scorteenergetiche muscolari, ragione per
cui iltempo di contrazione, ossia di lavoro,all’interno
di ogni serie deve essere relativamente
lungo, nell’ordine di 20-25 secondi,
e il recupero non del tutto completo,circa
1’-1’30’’. L’entità
ideale delcarico da utilizzare è
di circa il 70% diquello massimale, con
questo tipo di resistenzaè infatti
possibile eseguire circa10 ripetizioni,
a una velocità molto "controllata",per
un lavoro totale di circa 20secondi. La
pausa di 1’ - 1’30’’
in questecondizioni è ideale, non
permette infattiun recupero completo per
ciò che riguardai substrati energetici,
ma è comunquesufficiente per consentire
una successivaserie di lavoro. Molti autori
indicano in10 il numero ideale di serie
atte a un aumentodell’ipertrofia muscolare,
tuttaviaaltri sottolineano il fatto che,
soprattuttoper ciò che riguarda i
"piccoli" gruppimuscolari (come
ad esempio bicipiti otricipiti), potrebbe
essere eccessivo, sarebbequindi preferibile
un lavoro ad"alta intensità"
con recuperi ridotti ma che comporti un
numero inferiore di serie, in genere al
massimo sei.
La tipologia
delle fibre
Come è noto, le fibre rapide (FT),
soprattuttole glicolitiche pure (FTb), posseggonouna
maggior capacita contrattilerispetto a quelle
di tipo ossidativo (ST).La forza prodotta
durante una contrazionedi tipo tetanico
da parte di una fibradi tipo ST, è
infatti dell’ordine di circa140 mg
contro i circa 700 che possonoessere prodotti
da una di tipo FTb. Perquesto motivo le
unità motorie (UM)composte da fibre
ST possono esercitareuna tensione dell’ordine
di 2-13 grammi,mentre le UM composte da
fibre FTbsono in grado di produrre dai 30
ai 130grammi di tensione. Inoltre, come
abbiamoprima ricordato a proposito dell’ipertrofiamuscolare,
è importante ricordareche mettere
metabolicamente in "crisi" ilsistema
muscolare, ossia effettuare unaforte deplezione
dei suoi substrati energeticiin tempi brevi
con alta intensità dilavoro, significa
operare in pieno sistemaanaerobico lattacido.
Per tutti questimotivi, sia l’ipertrofia
muscolare sia lecapacità di forza
massimale (soprattuttonel caso in cui un’alta
percentuale diforza debba essere prodotta
in tempibrevi, ossia in condizioni di "fora
esplosiva"),sono fortemente legate
alla tipologiadelle fibre, e una maggiore
percentualedi quelle rapide costituisce
in questosenso un indiscutibile vantaggio.
Ilcambiamento della tipologia delle fibre,soprattutto
per ciò che riguarda la possibiletrasformazione
di fibre di tipo ST inFT, si rivela però
molto improbabileanche se alcuni recenti
studi in questocampo sembrerebbero provare
il contrario(Andersen e Agard, 2000).
La strutturazionesarcomerale
del muscolo
Da tempo è noto come un muscolo
immobilizzato in una posizione allungata,
andrebbe incontro ad un aumento
del numero dei propri sarcomeri in serie(Goldspink,
1985). Alla luce di questidati è
ragionevole avanzare l’ipotesi cheun
lavoro muscolare effettuato nel rispettodella
massima escursione articolare,possa sortire
degli effetti simili, provocandoun aumento
in serie dei sarcomeridei muscoli sollecitati.
D’altro canto, èpensabile anche
il contrario, ossia che lavorandosistematicamente
con escursioniarticolari incomplete, nel
muscolo diminuiscanoi sarcomeri in serie.
L’aumento del numero dei sarcomeri
inserie, costituirebbe un fattore molto
importanteper la capacità di velocità
dicontrazione del muscolo, se infatti leforze
di un muscolo si sommano in parallelo(come
abbiamo visto nell’esempiodell’estensore)
è altrettanto vero cheper le velocità
si verifica lo stesso fenomeno,maggiore
sarà il numero dei sarcomeriquesta
volta in serie (e non in parallelocome nel
caso della forza), maggiorerisulterà
la capacità di accorciamentodel muscolo
(figura 4).
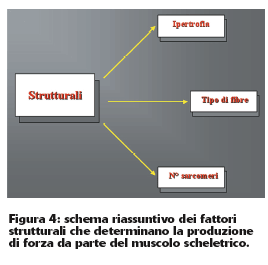
Questotipo
di adattamento sarebbe di fondamentaleimportanza
soprattutto nell’aumentodella capacità
di forza veloce edesplosiva del muscolo,
non a caso alcunirecenti lavori evidenziano
che le fibredel muscolo quadricipite dei
velocisti dialto livello sono più
lunghe rispetto aquelle dei sedentari. Per
cercare di forzarel’adattamento muscolare
in tal senso,occorre quindi effettuare gli
esercizi dipotenziamento muscolare cercando
diosservare il più ampio range di
escursionearticolare possibile.
I fattori
nervosi
Sono essenzialmente riconducibili altipo
di reclutamento seguito dai diversitipi
di fibre muscolari durante il movimentonaturale.
Un’interpretazione classicadei principi
fisiologici che reggonoil reclutamento delle
fibre, è data dallalegge di Henneman
e coll. (1965) cheenuncia come, indipendentemente
daltipo e dalla velocità del movimento
considerato, le prime fibre a essere reclutate
siano quelle a contrazione lenta.Quest’interpretazione,
è stata confortatain seguito anche
dai risultati ottenuti daCostill (1980)
che, come è possibile notareanche
nello schema seguente (figura 5),
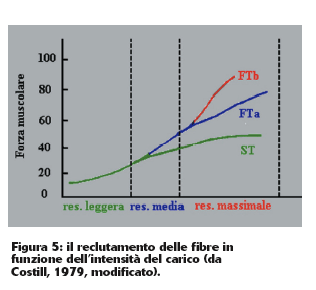
mostrano
come un movimento effettuato contro
una resistenza esterna didebole entità,
comporti un reclutamentoselettivo delle
fibre di tipo ST, mentre unmovimento effettuato
contro un caricoesterno medio, richieda
anche l’interventodelle fibre di tipo
FTa e come, infine,un movimento effettuato
contro un carico esterno di notevole entità
richieda l’intervento di tutti e tre
i tipi di fibre.Tuttavia, la legge di Henneman
è stata rimessain discussione da
numerosi autori,nel caso in cui il movimento
sia eseguitoin modo balistico, in pratica
quando laforza prodotta è direttamente
proporzionaleall’accelerazione generata,
secondol’equazione F = M · a,
nella quale F è laforza espressa
in N, M la massa espressain kg e a l’accelerazione
espressa in m. s-2e tale forza tenda al
valore massimale.In questo caso, le unità
motorie rapidepotrebbero essere reclutate
direttamente,senza l’intervento di
quelle costituite da fibre a contrazione
lenta (Grimby e Hannertz, 1977).L’esempio
del salto in questo caso è abbastanzadelucidante,
poiché nel suosvolgimento la forza
espressa è pari acirca il 40% della
forza isometrica massimaledel soggetto,
tuttavia la forte attivitàelettromiografica
registrabile durantequesto tipo di movimento
indica unreclutamento selettivo delle fibre
a contrazionerapida.Dobbiamo comunque sottolineare
che leopinioni in quest’ambito divergono
notevolmente,altri autori, infatti, riferisconocome
la legge di Henneman sia rispettataanche
durante un movimento di tipo balistico(Desmet
e Godaux, 1980), mentrealtri ancora ritengono
che questo principiodi reclutamento sia
rispettato solonel caso di gruppi muscolari
aventi, bio- meccanicamente, più
funzioni, unicamente nell’espletamento
delle proprie funzione principali (Cometti,
1988).Altri due aspetti concernenti la regolazionedi
tipo nervoso della produzione diforza, sono
costituiti dalla sincronizzazionedelle unità
motorie nell’effettuazionedel gesto
e dalla coordinazione intermuscolareche
si esplica nel gestostesso. Anche in quest’ambito
esistonodelle metodologie di allenamento,
comelo stato-dinamico o il bulgaro orientatomodificato,che
purtroppo per ragioni dispazio non possiamo
che ricordare senzaentrare nei dettagli.
Le proprietà
elastichedel complessomuscolo-tendineo
Il complesso muscolo-tendineo umanopossiede
notevoli proprietà elastiche.Nella
fase eccentrica del movimento, infatti,soprattutto
il tendine immagazzinaenergia elastica,
che poi restituisce sottoforma di lavoro
meccanico nella successivafase concentrica.
Durante la fase eccentrica della corsa,
adesempio, il tendine di Achille è
allungatodi circa il 6%, pari a circa 1.5
cm rispettoalla sua lunghezza iniziale,
e restituiscecirca il 90% dell’energia
elastica potenzialeimmagazzinata, sotto
forma di lavoromeccanico, nella successiva
fase concentricadel movimento.
In tal modo, il rendimento muscolarepassa
dal 25% a oltre il 40%, l’energia elasticaè
infatti "metabolicamente gratuita",per
questo motivo riveste un ruolo essenziale,
sia nel potenziamento sia nell’economia
del gesto del muscolo stesso.Il fatto di
eseguire un movimento attraversoun ciclo
stiramento-accorciamento(SSC), ottiene come
risultato un aumentodella forza, della velocità
e della potenzaespressa durante la fase
concentrica .L’aumento di questi tre
parametri, in ultima analisi, è il
vero significato della frase: restituzione
di energia elastica.Oltre che con il lavoro
pliometrico, le capacitàdi immagazzinamento
e restituzionedi energia elastica da parte
del complessomuscolo-tendineo, possono essereallenate
attraverso l’utilizzo di carichipari
a circa il 30-35% del valore di forzamassimale
dell’atleta, effettuati alla piùalta
velocità esecutiva possibile.
Quale
e quanta forza per il calciatore?
Di quale
tipo di forza necessità il calciatore?E
quanto allenamento di forzadeve svolgere?In
primo luogo, il modello prestativo delcalciatore
è molto lontano da quello dellottatore
o del lanciatore di peso, tipologieatletiche
che necessitano di notevoleforza massimale
e di altrettanto importanticapacità
di forza esplosiva. Non ritengoperciò
necessarie metodologie di allenamentodella
forza molto "spinte", comead esempio
l’eccentrico o il Pletnev (la combinazione
di tre o quattro diversi regimidi contrazione).
Questi tipi di allenamentorichiedono un
"vissuto atletico", intermini
di esperienza con i sovraccarichi,che non
fa certamente parte del backgrounddella
maggior parte dei giocatori. I benefici
che si possono tratte da questitipi di lavoro,
in termini di miglioramentodella prestazione
calcistica, non sono,tutto sommato, proporzionali
ai potenzialirischi rappresentati dal possibile
eccessivo sovraccarico funzionale. Per il
calciatore che voglia avvicinarsi all’allenamento
della forza con l’utilizzo dei sovraccarichi,
consiglierei un approccio graduale e soprattutto
metodologicamente razionale e articolato
in 3 tappe.
1°
tappa: definibile di "consolidamento
tecnico e condizionamento muscolare generale".
In questo periodo, che può variareda
4 a 6 settimane, si deve acquisireuna buona
tecnica esecutiva in tutte leesercitazioni
proposte nel piano di lavoro,nonché
conseguire un condizionamento muscolare
di base che permetta inseguito di affrontare
più agevolmente i lavori più
specialistici. La metodologia di lavoro
di questo primo periodo, che possiamo definire
propedeutico, è senz’altro da
basarsi sulla contrazione concentrica, effettuata
a velocità controllata, allo scopo
di sensibilizzare il movimento e il gruppo
muscolare interessato. Giudicherei errato,
in chi si avvicina per la prima volta alla
pratica dell’allenamento di muscolazione,
ricercare subitoun movimento esplosivo,
si rischierebbe di cadere in una cattiva
esecuzione tecnica dell’esercizio,
accompagnata da una scarsa "sensibilità"
muscolare nei confrontidello stesso.
2°
tappa: dopo aver acquisito una buona
padronanza esecutiva degli esercizi unita
a un altrettanto soddisfacente sensibilità
muscolare e a un buon consolidamento dei
carichi utilizzati nelle esercitazioni stesse
— si possono introdurre metodiche che
pongano l’accento sulla forza esplosiva.
Particolarmente adatti aquesto scopo il
metodo bulgaro, quello contrasto o un metodo
di incremento classico della potenza che
vede l’utilizzo di carichi pari a circa
il 50% di quello massimale, eseguiti a velocità
massimale. In questo caso, la serie è
interrotta non appena la velocità
esecutiva tende a calare visibilmente, o
ancor meglio se l’intera serie viene
"monitorizzata" grazie a un apparecchiatura
in grado di fornire
in tempo reale la potenza espressa.
Un ottimo complemento per questo tipodi
lavoro è un programma di trasformazionein
forza speciale, a base di balzi,andature
elastiche, sprint, e/o di forzaspecifica,
basato su gesti tecnici come ilcalciare,
il colpire di testa…
3°
tappa: contestualmente alla seconda
tappa — che prevede l’introduzione
dimetodologie di lavoro atte all’allenamento
della forza esplosiva con conseguente trasformazione
in forza speciale e/o specifica — occorre
inserire un secondo tipo di lavoro che ponga
l’accento sulla resistenza alla forza
veloce.
Ricordate quanto detto nell’articolo
apparsosu questa stessa rivista nel numerodi
marzo 2001 intitolato "Come salvarsidal
terremoto"? Mi sembrano particolarmente
indicati a questo scopo i circuiti d itipo
"intermittente-forza", impostati
sulla falsa riga di quelli riportati nell’articolo
in questione.
A questo punto, qualcuno potrebbe sollevare
un’eccezione più che legittima:
con questo tipo di lavoro non si allena
né la potenza aerobica né
la forza. Verissimo, ma è altrettanto
vero il fatto che la potenza aerobica merita
sempre e comunque un posto ben preciso nel
microciclo settimanale di allenamento e
che la forza dovrebbe essere già
allenata singolarmentee in modo specifico
con la metodologia illustrata alla seconda
tappa.
Di conseguenza,l’intermittente-forza
non è un melange mal riuscito tra
forza e potenza aerobica, ma al contrario
un ottimo metodo per allenare la forza veloce
in regime di fatica, concetto che farà
anche storcere il naso ai puristi dell’allenamento
,ma che, ahimè per loro, ricalca
esattamente quello che fisiologicamente
avviene in situazione di gioco.
|
